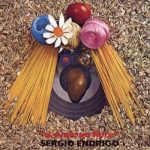Monthly Archives: Maggio 2014
Io freno anche per i ricci

È oramai primavera inoltrata e i ricci (1), dopo essere usciti dal letargo ai primi caldi soli, sono nel pieno della loro attività. I ricci sono animali notturni caratterizzati dalla presenza di aculei (ben 6-7 mila) nella parte superiore del loro corpo, evoluzione dei peli per scopi di difesa dai predatori.
Questi aculei rappresentano la loro fortuna evolutiva ma anche la loro condanna moderna. Infatti sono talmente efficaci contro i predatori che l’animale, in caso di pericolo, ha sviluppato l’istinto di appallottolarsi e di mettere la testa sotto il ventre per rimanere lì. Fermo. Ad aspettare che il pericolo se ne vada.
Purtroppo i pericoli moderni per i pochi ricci superstiti in un ambiente fortemente antropizzato e sottoposto ad agricoltura intensiva com’è quello delle nostre campagne, non sono più in larga parte i rapaci o i piccoli carnivori. Tali pericoli sono invece rappresentati dagli autoveicoli che sfrecciano sempre più numerosi e sempre più veloci nel nostro reticolo stradale urbano.

Per questo e per evitare inutili stragi, a chi per strada mi sta dietro dico di fare attenzione perché… io freno anche per i ricci!
P.S. Scaricate il cartello, stampatelo e attaccatelo sul vetro della vostra auto per segnalare che anche voi frenate per i ricci.
_____
(1) Il riccio è un mammifero notturno appartenente alla specie degli Erinaceidi caratterizzato dalla presenza di aculei sulla parte superiore del corpo che fungono da sistema di difesa dai predatori. l riccio è un animale onnivoro la cui dieta include insetti, lumache, rane, uova di uccelli e vari vegetali. Ama la frutta, i vermi e tutti gli animaletti che popolano il sottobosco. Può arrivare a mangiare uccelli di piccola taglia, topi e serpenti. Il riccio può anche affezionarsi alle persone e, per questo, può vivere anche in ambienti domestici.
Foto: il corpo di un riccio investito per strada – foto di Matteo Di Nicola
L’assurdo spreco di cibo negli USA

Negli Stati Uniti si spreca circa il 40% del cibo prodotto, pari ad un valore di circa 165 miliardi di dollari. Si tratta di cibo buono, non avariato, spesso non cucinato, che viene gettato nella spazzatura ancora confezionato direttamente da parte degli acquirenti. La causa più frequente è legata al raggiungimento e al superamento della data di scadenza (anche se non è detto che il cibo sia immangiabile!) dovuti alla sovrabbondanza di cibo presente nelle dispense di una famiglia media che, semplicemente, ne acquista troppo e si dimentica di averlo.
E pensare che questo cibo potrebbe anche aiutare quei 50 milioni di americani (circa il 16% della popolazione totale degli USA) che sono poveri e fanno fatica a procurarsi da mangiare.
Per spiegare questo fenomeno è interessante osservare l’esperienza di Nick Papadopulos, un agricoltore biologico californiano. Stanco di buttare intere cassette di frutta o verdura rimaste invendute, Papadopulos ha iniziato a confrontarsi con altri produttori locali interessati dallo stesso fenomeno. La sua soluzione è stata quella di creare CropMobster, un servizio per trovare persone interessate a comperare, a prezzi più vantaggiosi, prodotti invenduti.
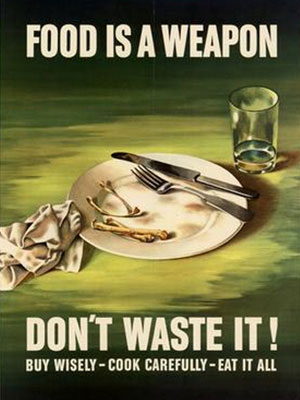 L’ampliamento del mercato, però, non è l’unica strada da percorrere per risolvere il problema. Servirebbe anche più informazione dei cittadini sia sull’alimentazione che sulle questioni tecniche legate alla coltivazione, alla trasformazione e alla conservazione del cibo. Innanzitutto bisognerebbe insegnare loro a non acquistare il cibo solo per il suo bell’aspetto estetico ma, soprattutto, a tener conto della sua qualità. Inoltre bisognerebbe spiegare loro che le date di scadenza riportate sulle confezioni non sono valide in senso assoluto ma forniscono solamente un’indicazione di massima. Prima di consumarlo, il cibo, deve essere sempre assaggiato. Anche se ciò avviene entro la data di scadenza!
L’ampliamento del mercato, però, non è l’unica strada da percorrere per risolvere il problema. Servirebbe anche più informazione dei cittadini sia sull’alimentazione che sulle questioni tecniche legate alla coltivazione, alla trasformazione e alla conservazione del cibo. Innanzitutto bisognerebbe insegnare loro a non acquistare il cibo solo per il suo bell’aspetto estetico ma, soprattutto, a tener conto della sua qualità. Inoltre bisognerebbe spiegare loro che le date di scadenza riportate sulle confezioni non sono valide in senso assoluto ma forniscono solamente un’indicazione di massima. Prima di consumarlo, il cibo, deve essere sempre assaggiato. Anche se ciò avviene entro la data di scadenza!
Lo spreco di cibo è una follia. Lo è sia dal punto di vista umano ed etico che dal punto di vista di sostenibilità ambientale. Produrre cibo “consuma” lavoro, energia, materie e produce inquinamento, diretto o indiretto. Purtroppo l’agricoltura è stata interessata da un progressivo fenomeno di industrializzazione che l’ha spinta, come per le produzioni meccaniche, chimiche o altro, verso l’obiettivo della massimizzazione della produttività e l’abbassamento dei prezzi, preoccupandosi relativamente della qualità. Ma il cibo, si sa, è molto diverso da un manufatto. Lo ingeriamo e, attraverso il metabolismo, diventa noi e noi diventiamo un po’ lui.
Paradossalmente, per risolvere il problema dello spreco di cibo ancora buono, si dovrebbe fare una cosa semplice e apparentemente assurda. Si dovrebbe puntare all’aumento dei prezzi di vendita. In un sistema industriale che tende a massimizzare la produzione e a fornire cibo a prezzi bassi ma a discapito della qualità, si dovrebbe aumentarne il valore per far comprendere ai cittadini la sua vera importanza.
_____
Fonte: Internazionale
Il pesce è sempre più caro? La colpa è degli Omega-3

Su “Il Venerdì di Repubblica” del 28 febbraio scorso Loretta Napoleoni, economista, nella sua rubrica “Follow the money” parla dei motivi per cui il pesce è caro (anche quello di allevamento).
Per argomentare le sue tesi scrive: “Quest’anno mangeremo più pesce di allevamento che selvaggio […]. Il motivo è presto detto: da oltre un decennio la domanda ittica mondiale aumenta a un ritmo che oscilla tra il 5 e il 10 per cento annuo e i responsabili sono in primis i Paesi in via di sviluppo, man mano che si arricchiscono cresce la voglia di mangiare pesce […]. Il pianeta mangia pesce ad un ritmo molto più elevato di quello della riproduzione, anche dell’allevamento”.
Sacrosante parole. “Secondo le previsioni – prosegue l’articolo – l’allevamento ittico aumenterà ancora di un 14 per cento prima di raggiungere il massimo della capacità, a meno che non si verifichi un cambiamento radicale, come una rivoluzione tecnologica che permetta di rimuovere l’ostacolo maggiore: per produrre il pesce bisogna usare come alimento principale il pesce”.
“Prendiamo il salmone, forse il pesce più gettonato al mondo, la dieta di quello di allevamento deve contenere una certa quantità di Omega-3, che si trova principalmente nei pesci dell’America Latina, che iniziano a scarseggiare. Questo spiega perchè dal 2013 il costo del salmone è in netto aumento […]. Ora la Monsanto sta studiando la possibilità di estrarre Omega-3 dalla soia, e altre multinazionali sperimentano l’utilizzo delle alghe. Una cosa è certa: finché qualcuno non trova la formula giusta, il prezzo del salmone continuerà a salire”.
Cara sig.ra Napoleoni, per risolvere il problema del prezzo del pesce che cresce a causa del depauperamento degli stock ittici che non sono oramai più in grado di soddisfare né la richiesta mondiale di pesce selvaggio né quella dell’industria dei mangimi per il pesce di allevamento non si può solo ragionare in termini di tecnica e di tecnologia. Non si può solo pensare che la soluzione possa essere quella di ottenere gli Omega-3 attraverso l’uso abbondante di energia per estrarli a forza dai prodotti agricoli come la soia o le alghe (che potrebbero essere consumati anche direttamente) al solo scopo di alimentare l’industria dell’allevamento. In più mettendo in competizione il mondo agricolo che produce direttamente cibo con quello che produce beni per l’industria.
La soluzione potrebbe (e dovrebbe) essere, invece, quella che passa attraverso il concetto della “sufficienza”, cioè l’ottenimento del benessere per la più ampia fetta possibile di popolazione mondiale attraverso la riduzione dei livelli di consumo e il miglioramento in termini qualitativi del consumo attuale. Nell’ambito del prezzo in aumento del pesce questo concetto della sufficienza dovrebbe esprimersi sostanzialmente in due direzioni fondamentali:
- diminuire i consumi di pesce e crostacei per quella fetta ricca della popolazione mondiale che ne consuma (e spesso ne getta) troppi;
- orientare i consumi alimentari verso i vegetali (di qualità, altrimenti finiamo dalla pentola alla brace) piuttosto che verso le carni.
La ragnatela urbana

Avete presente quelle splendide ragnatele che talvolta, di mattina presto, in controluce e, magari, evidenziate anche dalla brina, si disegnano tra i rami degli alberi? Se siete fortunati che qualcuno e qualcosa non le abbia rovinate le potete vedere nella loro interezza cogliendo appieno la loro struttura: una forma che, da un punto centrale parte a raggiera e che ha i raggi portanti della struttura uniti tra loro da segmenti, via via sempre più lunghi e radi più ci si allontana dal centro. Una trappola invisibile, perfetta, per insetti volanti che vi dovessero finire sopra.
Ora, provate a mettere in orizzontale la ragnatela e a trasporla, in dimensioni maggiori, su un qualsiasi territorio, meglio se pianeggiante e senza ostacoli. La potete notare meglio di sera, con i lampioni accesi, ora che l’illuminazione notturna ha raggiunto (ahimè!) anche le strade più remote. Vedrete che la sua forma ricalca perfettamente la struttura delle città e delle sue vie di comunicazione: il fulcro è il centro urbano e i fili delle ragnatele sono le strade o la ferrovia. Quelle a raggiera sono le principali mentre quelle di congiunzione dei raggi sono quelle secondarie, di quartiere o, via via che ci si allontana dal centro, quelle più rade di periferia e di campagna.
Come quella del ragno anche la “ragnatela” del territorio (ragnatela urbana, la si può definire) la potremmo considerare un’enorme trappola. Che non fa prigionieri e morti come quella del ragno ma che porta l’urbanizzazione sempre più lontano dalle città divorando sempre più territorio, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno.
La ragnatela urbana è la conseguenza dei comportamenti e delle decisioni scellerate degli amministratori pubblici per portare “progresso” e “benessere” (e, spesso, anche interessi economici personali e lobbistici) perché si devono costruire nuove strade, per poi fare nuove aree industriali, per poi costruire nuove case, per poi fare nuovi ponti, per poi fare nuove valutazioni di impatto ambientale, per poi fare nuovi progetti, per poi ottenere nuovi finanziamenti, per poi fare nuove strade, per poi…
La ragnatela urbana è anche la conseguenza delle richieste avanzate dagli imprenditori per garantire competitività alle proprie imprese: più vie di comunicazione uguale più facilità nei trasporti e nella movimentazione delle merci e dei prodotti. Inoltre costruire case, aree industriali e infrastrutture è, per loro, anche un ottimo sistema per diversificare gli investimenti.
E noi, cittadini, in mezzo, informati da un sistema di comunicazione che tende ad indagare poco perché non indipendente dai “poteri”, che ci beviamo un po’ tutto convinti che vada bene così.
Al di là di quello che ci viene detto a me sembra che la ragnatela urbana sia piuttosto una trappola e lo proverò a spiegare.
Innanzitutto la ragnatela urbana consuma territorio prezioso sia per l’agricoltura e la sovranità alimentare che per il paesaggio, fonte di reddito nell’ambito turistico. Poi, la ragnatela urbana è inefficiente perché esplode le città e le distribuisce su un territorio sempre più ampio, rendendo più complessi tutti i trasporti: dalle merci, alle informazioni, all’energia. Inoltre la ragnatela urbana contribuisce ad incrementare il consumo di energia, sia per costruirla che per gestirla, oltre che ad avere un effetto indiretto di distribuzione generalizzata dei fenomeni inquinanti.
La natura – che è sempre in lotta con il reperimento dell’energia a basso sforzo e per risparmiarla – a guardarla bene, invece, produce strutture collettive compatte, le uniche in grado di minimizzare gli sforzi e, al contempo, massimizzare le relazioni.
Sulla base di questo principio è necessario che da subito i Comuni e le Regioni inizino a praticare l’obiettivo di consumo netto del territorio (1) pari a ZERO senza attendere i fantomatici regolamenti comunitari o le leggi nazionali, che non arriveranno mai perché realizzate da chi ha anche interessi personali diretti e indiretti sull’edilizia e sulla realizzazione delle infrastrutture.
_____
(1) Per consumo netto del territorio si intende solo il consumo del territorio vergine, al netto dei recuperi effettuati su territorio già urbanizzato.
Salute e sostenibilità ambientale sono concetti strettamente interconnessi

La sostenibilità ambientale passa inevitabilmente attraverso la salute e la salute passa attraverso la sostenibilità ambientale, in un pieno rapporto biunivoco. Senza la sostenibilità ambientale non ci può essere salute (soprattutto prevenzione, che è la componente più importante della salute) e senza salute (cioè senza una chiara idea di che cosa sia la salute e la prevenzione) non ci può essere sostenibilità ambientale.
Provo a fare degli esempi. Chi abusa dei farmaci (necessari, ma pur sempre tossici) per togliere qualsiasi sintomo senza preoccuparsi delle cause che lo determinano come può avere una chiara idea di che cosa sia la sostenibilità ambientale? Chi mangia male (cibo spazzatura) e specula sul prezzo del cibo (consumando cibo di bassa qualità) per avere più beni effimeri e non necessari come può agire per perseguire la sostenibilità ambientale? Chi butta la spazzatura a terra anziché adoperarsi per smaltirla correttamente come può capire a fondo cosa sia la salute e la prevenzione? Chi abusa di pesticidi e diserbanti (in agricoltura, negli spazi pubblici, negli spazi verdi privati) come può adoperarsi correttamente per garantire salute a se stesso e ai propri cari nel lungo periodo? E gli esempi potrebbero essere innumerevoli…
A tale proposito qualche giorno fa sono rimasto colpito da un bell’articolo del dott. Roberto Gava pubblicato su Il Fatto Quotidiano nel quale afferma un concetto fondamentale per ragionare in termini di salute e di sostenibilità ambientale: noi stessi siamo la causa delle nostre patologie (e del nostro benessere, aggiungo io).
Quello che afferma il dott. Gava – basandolo sulla propria esperienza clinica – è il fatto che la quasi totalità delle nostre patologie attuali – spesso croniche e invalidanti – sia il frutto di errori pubblici e sociali (ad esempio tollerare ancora elevati tassi di inquinamento per alimentare un sistema economico senza fine basato sulla continua produzione e consumo) e sulla scarsa cultura della prevenzione da parte delle persone. In tutto questo, io mi chiedo dove erano e dove sono i medici e i farmacisti? Qual è il loro ruolo nel rapporto con i pazienti all’interno del processo di mantenimento della salute e di cura? Cosa sanno e cosa percepiscono veramente della salute attraverso la prevenzione e del ruolo che ha la sostenibilità ambientale nel garantirla?
Per promuovere la salute il dott. Gava parla, nel dettaglio, di prevenzione alimentare e dei principali errori che si commettono nel campo della nutrizione:
- Troppi zuccheri semplici, comprendendo quelli che aggiungiamo noi e quelli che aggiunge l’industria alimentare.
- Troppi cereali, rispetto a verdure, legumi, frutta e proteine vegetali.
- Troppi carboidrati raffinati rispetto a quelli complessi.
- Troppi grassi saturi (grassi animali) e pochi grassi buoni (polinsaturi omega-3 di origine vegetale o ittica e monoinsaturi dell’olio di oliva).
- Carenza di micronutrienti essenziali: la produzione industriale del cibo li ha gravemente ridotti, insieme allo sfruttamento del terreno e all’inquinamento (viviamo in una situazione di carenza cronica che, di solito, non induce avitaminosi, ma altera il metabolismo dell’organismo e induce una instabilità genomica con maggior suscettibilità al danno del DNA con scarsa capacità di ripararlo).
- Carenza di fibra alimentare (assente in cibi raffinati) con conseguenti: stipsi, accumulo di sostanze tossiche, mancato legame di zuccheri e grassi (che verrebbero escreti più facilmente riducendo anche il colesterolo-LDL e aumentando il colesterolo-HDL) e aumento di diabete e vasculopatie aterosclerotiche.
- Alterazione dell’equilibrio acido-base con spostamento verso l’acidosi metabolica a causa di eccessivo consumo di cibi acidificanti (cibi confezionati, carne, uova, latte, formaggi, sale, additivi chimici, ecc.) a cui conseguono: perdita del tono muscolare, osteoporosi, calcoli renali, ipertensione arteriosa, infiammazione tessutale, ecc.
- Alterato equilibrio sodio/potassio con aumento del sodio (contenuto in abbondanza nei cibi industriali) e calo del potassio (che è scarso in carboidrati raffinati, latte e formaggi), con conseguente aumentato rischio di ipertensione arteriosa, ictus cerebrale, calcoli renali, osteoporosi, asma, insonnia, ecc.
Oltre a tener conto dei punti precedenti tra le possibili soluzioni elenca:
- La riduzione dell’introito calorico quale miglior modo per rallentare l’invecchiamento e per prevenire le patologie croniche;
- La restrizione calorica quale modo per facilitare l’eliminazione di cellule danneggiate e la loro sostituzione con cellule nuove derivate dalle riserve staminali.
A ciò io aggiungerei anche:
- La scelta di prodotti alimentari coltivati e prodotti con il minor impatto ambientale possibile che, per semplificazione, potrebbero essere quelli certificati biologici o biodinamici, sono fondamentali per limitare l’inquinamento e garantire più alti livelli di salute sociale nonché per fornire cibi più sani alle persone;
- La scelta di prodotti alimentari locali che vengono coltivati o prodotti vicino al luogo di consumo viaggiano di meno: in tale modo possono essere raccolti al raggiungimento della maturazione e, per questo, possono garantire maggiore e migliore apporto di vitamine e nutrienti;
- La scelta di prodotti alimentari semplici e non troppo industrializzati. In tal modo si limitano inutili additivi (conservanti e insaporenti) e si garantisce più genuinità dei cibi;
- La scelta di prodotti alimentari che abbiano pochi imballaggi per limitare la produzione dei rifiuti che indirettamente, attraverso l’inquinamento che producono, possono contribuire a diminuire la qualità della salute pubblica.
_____
Foto: La nuova piramide alimentare